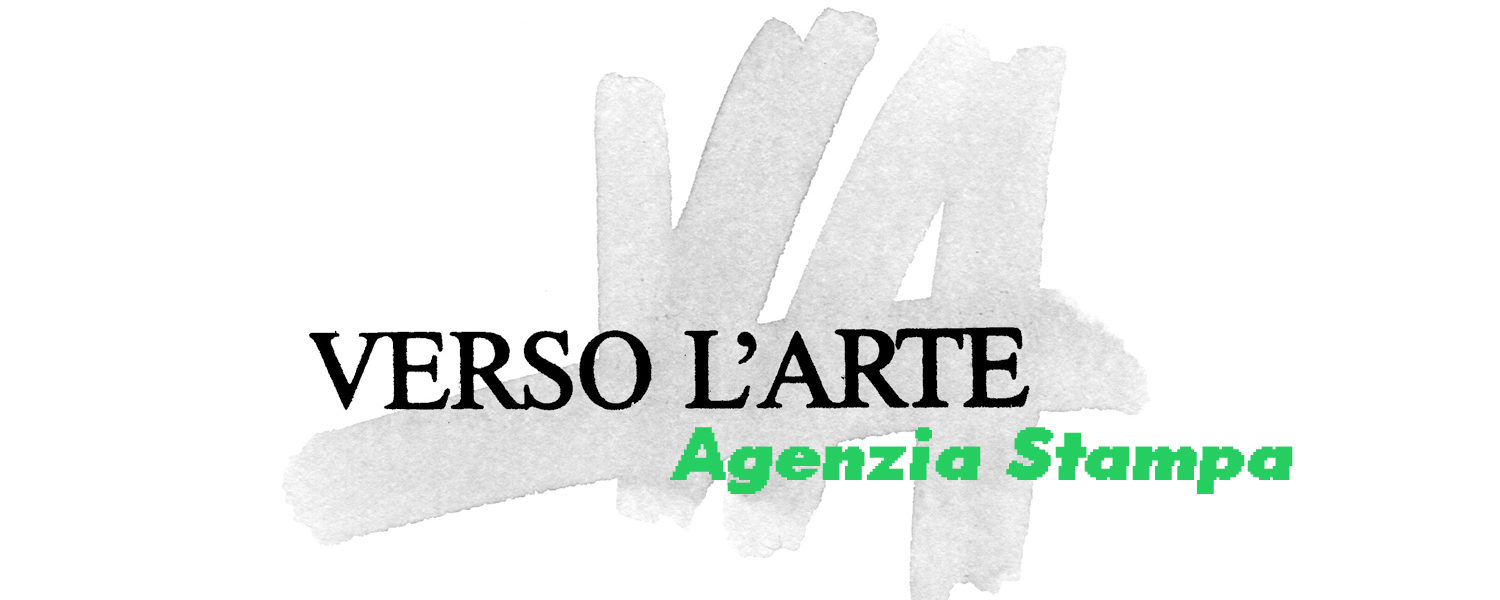L’Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con la Fondazione Baruchello, con il patrocinio e sostegno dell’Associazione Amici dell’Accademia Nazionale dei Lincei, fino al 3 maggio espone a Villa Farnesina a Roma la mostra “Gianfranco Baruchello. Mondi Possibili”, a cura di Carla Subrizi, in concomitanza con il Convegno Internazionale di Studi “Il Possibile: Istruzioni per l’uso. Studi sull’opera di Gianfranco Baruchello”, tenutosi lo scorso gennaio presso l’Accademia Nazionale dei Lincei. Entrambi gli eventi fanno parte delle iniziative per il centenario della nascita di Gianfranco Baruchello (Livorno 1924 – Roma 2023).

La mostra, in un percorso che si snoda tra gli spazi interni ed esterni di Villa Farnesina, propone, con una selezione di opere di Gianfranco Baruchello, un dialogo a distanza tra storia, iconografie e immaginari appartenenti a epoche differenti. Arte e storia si aprono a un confronto tra passato e presente.
La storia, l’inconscio, il sogno e l’ambiente, temi tutti presenti nei cicli degli affreschi di Villa Farnesina, sono stati continuamente indagati da Baruchello e tornano in questa mostra, con otto grandi opere, attraverso una molteplicità di media differenti, tra cui la pittura, l’oggetto, l’installazione, l’immagine in movimento.
Se Raffaello pensa Galatea attraverso le Metamorfosi di Ovidio, Baruchello si autoritrae nel corso di un fiume, in un’opera lunga ben 15 metri, che nel suo articolarsi, scopre la difficoltà a fluire, a essere quel che dovrebbe, a causa di alterazioni degli equilibri sia naturali (ambientali, geografici, sociali) che dell’esperienza vissuta.
Anche le altre opere della mostra dialogano con gli ambienti della Villa Farnesina. Case nomadi e fragili (La Casa in fil di ferro, 1975, nella Sala del Fregio); monumenti a coloro che sono stati dimenticati dalla storia (Monumento ai non eroi, 1962, nella Sala delle Nozze di Alessandro Magno e Rossane); riflessioni sulla cartografia di un territorio attraverso una geografia “sensibile” (Rilievo ideale, 1965, nella Sala 5); stratificazioni sia temporali che spaziali della complessità dei cicli pittorici di Villa Farnesina colte nella misura ridotta di uno spazio non grande (Oh, Rocky Mountains Columbine, 1966, nella Saletta pompeiana); sguardi che dalla storia continuano a guardarci e a interrogarci (La storia ci guarda, 1972-2018, Sala 4); oggetti apribili che mostrano l’inconscio, la memoria e territori delle psiche ancora da esplorare (Murmur, 2015, nella Loggia di Amore e Psiche); un giardino di piante molto belle e seducenti che si rivelano essere in grado di costituire un pericolo (Giftpflanzen, Gefahr! (Piante velenose, pericolo!), 2009, nei giardini storici di Villa Farnesina).