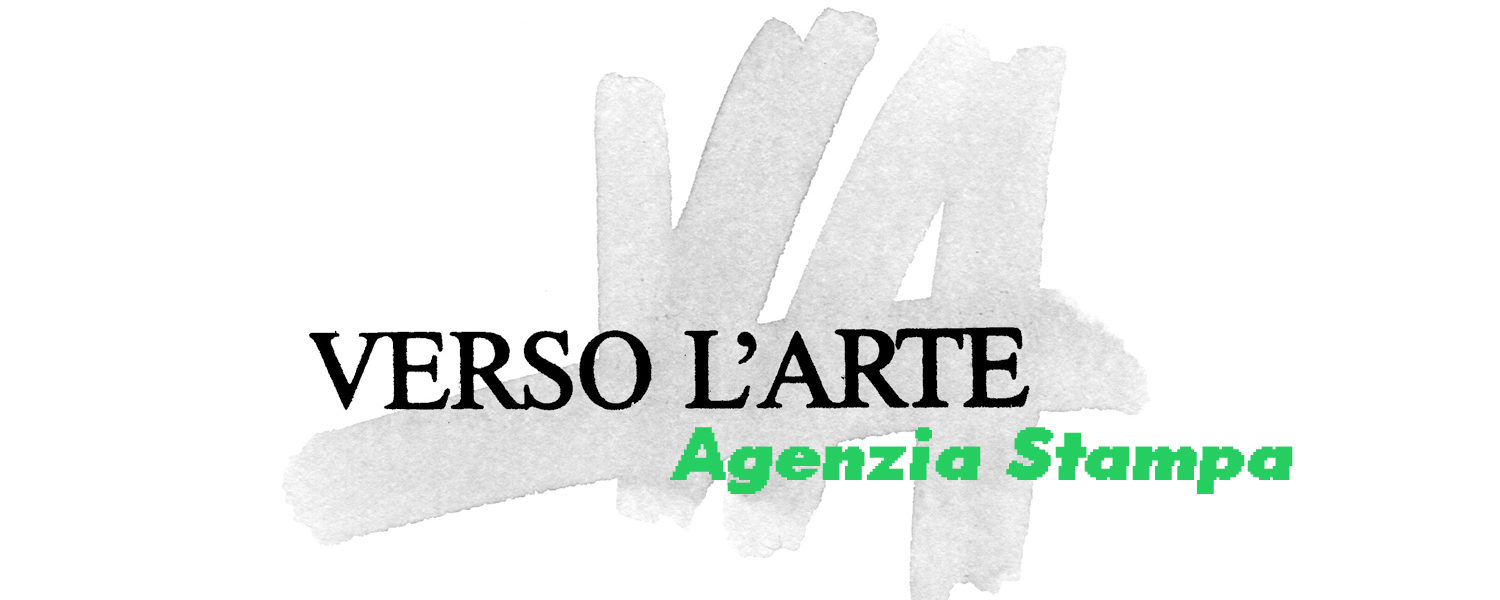Fino al 13 settembre prossimo, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli, è ospitata la mostra “Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista” a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza. L’esposizione rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’artista e si propone di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, molto più ricco e vario di quanto si sia soliti pensare. Il percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, grazie a importanti collaborazione istituzionali che permettono un approccio originale sia alle opere d’arte, sia al lavoro della bottega dell’artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, infatti, conserva alcune opere autografe di grande rilevanza che permettono di esemplificare i momenti principali della carriera dell’artista: “L’Eterno e la Vergine”, due frammenti della Pala di San Nicola da Tolentino (1500-1501) prima opera nota del diciassettenne Raffaello, dipinta per la chiesa di Sant’Agostino di Città di Castello, distrutta alla fine del Settecento; il “Ritratto di Alessandro Farnese” (1511 circa) il giovane cardinale che tanti anni dopo diventerà il potente papa Paolo III; il “Mosé e il roveto ardente” (1514) cartone preparatorio eseguito per l’affresco della volta della Stanza di Eliodoro in Vaticano; la “Madonna del Divino Amore” (1516-18) dipinto tra i più ammirati dell’artista nel corso del Cinquecento, poi caduto nell’oblio e sottratto solo recentemente, anche grazie alle indagini scientifiche e al restauro, alla sfortuna critica in cui era caduto nel Novecento.
Ma Capodimonte conserva anche un’opera fondamentale di Giulio Romano, il principale allievo di Raffaello, la “Madonna della gatta” (1518-1520 ca.?), eseguita seguendo un modello del maestro, e di cui le indagini diagnostiche aiutano a comprendere meglio tanto la complessa genesi esecutiva, quanto le cause dei problemi che ne hanno resa problematica la conservazione. Una serie di copie, derivazioni, multipli, alcune delle quali forse elaborate nella bottega stessa dell’artista (Madonna del Passeggio, Madonna del Velo), altre per mano di artisti di prima grandezza per committenti importanti – è il caso della famosa copia del Ritratto di Leone X di Andrea del Sarto – dove la nozione di ‘copia’ costeggia quella di ‘falso d’autore’, e che secondo Vasari avrebbe ingannato lo stesso Giulio Romano – o forse per esercitazione, come il San Giuseppe dalla Madonna del velo realizzato da Daniele da Volterra. Queste, assieme ad altre realizzate da più meccanici copisti (Madonna Bridgewater) permettono di esplorare ad ampio raggio questo tipo di produzione, che costituiva larga parte dell’opera delle botteghe del Cinque e del Seicento e che oggi forma una parte enorme, anche se spesso trascurata, del nostro patrimonio artistico.
Il percorso espositivo si snoda in quattro sezioni: “Una scuola eccezionale: maestri e fratelli maggiori”; “Raffaello a Capodimonte: dall’inizio alla piena maturità”; “Una straordinaria fortuna: derivazioni, variazioni, copie, repliche”. Nell’ultima sala del percorso espositivo ci sono altre opere, tutte ritenute copie da composizioni di Raffaello ben note, ma molto diverse tra loro: la “Madonna del Passeggio”, la “Madonna di Loreto” (o del velo) e la “Madonna (Bridgewater)”.